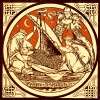Pubblichiamo uno dei lavori degli allievi del Seminario ADE sugli aspetti socioantropologici delle Migrazioni tenuto dalla Prof.ssa Mariella Orsi e dal Prof. Gianluca Favero.
"Quando hai finito la scuola, vieni a lavorare da noi, vedrai che ti troverai bene" mi dice l’operatrice mentre si accende una sigaretta sulla scala d’emergenza, fuori dal comparto operatorio. Non è un granché come posto per fumare. Ci sediamo sui gradini, per terra c’è un portacenere colmo di mozziconi. Abbiamo appena finito di sistemare i ferri per la sterilizzazione. L’operatrice mi ha illustrato le procedure, mi ha fatto provare, entrare per un momento in quel ciclo di gesti precisi, misurati, quasi perfetti. E’ un’ esperienza nuova per me, tutto è nuovo per me qui dentro. "Quando la Sala ti entra dentro, non te la levi più di dosso, non vorresti più lavorare da un’altra parte" mi ha detto l’operatrice sussurrando come se fossimo in una chiesa. La Sala. Penso alla dottoressa che è stata appena operata, al suo volto perduto nel sonno profondo dell’anestesia, così simile ai volti che ho veduto nei giorni scorsi. Nella Sala tutti i pazienti si assomigliano. I volti si chiudono e nulla più vi traspare, né emozioni né dolore né cose in sospeso, tutto sembra risolto e superato. Persino la paura. E paradossalmente nella Sala questa giovane dottoressa non mi era sembrata poi così diversa dalla sua compagna di stanza, una signora bosniaca, di etnia Rom. L’abisso che divide queste due signore dove era finito in quelle ore sul tavolo operatorio? Prima di tornare in reparto passo nella stanza di osservazione a vedere la dottoressa. Si sta svegliando proprio ora. Sono contenta di essere lì in quel preciso momento in cui tutti si stanno rilassando e lì dentro non c’è nessuno. Sul monitor le curve si inseguono silenziose, regolari, rassicuranti. "E’ andato tutto bene" le dico e mi godo il suo sollievo, i lineamenti che si distendono in un accenno di sorriso, la vita che sta ritornando, che sta riprendendo il suo posto. E’ stata una lunga mattinata. Nelle Sale tutti hanno lavorato sodo. Ora c’è un momento di pausa, anche il mio turno è quasi finito. Non mi cambio nemmeno la casacca verde, saluto e infilo a passi veloci quella porta che da fuori appare spesso così enigmatica, così inquietante. Ho dentro un bisogno forte di vedere la gente, i parenti, il via-vai dell’ora del passo, qualunque cosa, pur di uscire da questo silenzio a cui non mi sono ancora abituata. Magari anche quel bambino che passa delle ore a correre su e giù per il reparto. E’ il figlio della signora della Bosnia, non fa nient’altro, corre e basta, con i piedi nudi e la maglia della fiorentina troppo grande per lui, come se non avesse bisogno di niente, solo di quel movimento per sentirsi vivo. "Ma questi zingari, quando ce ne libereremo una buona volta" dice una signora ad alta voce proprio quando sto entrando nel corridoio. "Appena hanno qualcuno all’ospedale, invadono il reparto, è una cosa scandalosa." Dentro la stanza saranno sei o sette persone, un uomo, delle donne, un paio di bambini. Parlano concitati, uno sopra l’altro, a voce alta. Non faccio in tempo a lanciare uno sguardo fugace che subito sento i loro occhi su di me. Sono occhi che trasmettono paura, dolore, e qualcosa d’altro, diffidenza o aspettativa, non riesco a capirlo, forse tutte e due le cose insieme. Mi accorgo che mi stanno parlando, è per via della divisa che porto. Penso che dovrei subito andare a chiamare gli infermieri. Ma non c’è verso di fermare queste persone che hanno iniziato a dirmi delle cose e ora vogliono arrivare fino in fondo. Capisco che in qualche modo devo provare ad aiutarli a trovare un po’ di calma. Se almeno si esprimessero uno alla volta! Cerco di seguire attentamente le loro parole. Quelle della signora sono come intrecciate tra loro in un discorso interminabile che in qualche modo mi sfugge. Il marito si esprime a scatti, mi sembra lucido e ostile. C’è anche una signora dal fisico imponente, con un viso largo coperto di rughe a formare quasi una rete, che ripete le stesse parole con la sua voce profonda, sembra quasi una cantilena. Sarà sicuramente la suocera. E penso all’effetto che fanno certi particolari insignificanti, alla durezza delle lingue dell’ Est Europeo, che si nota subito ed è come un marchio. Ti capita di vedere una persona e di non pensare a niente, ti sembra una persona qualunque, poi lei dice due parole, magari solo così per cortesia e tu subito pensi: è una dell’ Est, nella migliore delle ipotesi sarà una badante; laggiù sono persone dure, mica come noi, basta sentire come parlano. E invece il fatto è che quelle lingue sono proprio così da sempre, fin dal Medioevo e forse chissà da quanti altri secoli prima. Se cresci con quelle lingue, quando senti l’italiano ti sembra incredibile. Dici "Questi non parlano, questi cantano" e per quanto tu ci provi, quel canto non ti riesce, se ti va bene ci vogliono anni. Guardo la signora nel letto, ora mi fissa con gli occhi neri, tremendamente vivi, con dentro un qualcosa che brilla come i riflessi nell’acqua di un pozzo."Lo capisci o no che io voglio vivere ancora, sta dicendo in un italiano stentato, ho cinque figli, due sono lontani, è più di un anno che non li vedo. Lo capisci che mi aspettano", continua a dire mentre i colpi di sole sui capelli neri danno una strana luce a quel volto svuotato dalla malattia. Quei colpi di sole. Quando è arrivata, qualcuno subito ha detto: "Ma guarda un po’ queste zingare, vivono alle spalle nostre e che fanno? Si fanno pure le ‘meches’, non gli basta di sfoggiare tutto quell‘oro!" Il marito mi chiede: "Abbiamo ragione a voler vivere, non è vero? Vogliamo solo vivere, non essere trattati come animali, è male questo? Solo la vita, capisci, solo la vita e basta." Non so che rispondere, né all’una né all’altro, cerco qualche espressione di conforto, ma le frasi mi si sbriciolano nella testa prima di formarsi. Ce la devo fare, penso, almeno qualcosa la devo dire, non importa cosa a questo punto. Tanto forse non mi starebbero nemmeno a sentire, tutti presi dal bisogno prepotente di essere ascoltati, dal bisogno che qualcuno risponda del loro male senza senso, senza nome, qualcuno con un volto, aldilà del ciclo anonimo e ripetitivo delle terapie, delle macchine, delle cartelle cliniche. Tutte cose in cui non possono avere nessun ruolo, cose a cui ancora non riescono dare un senso. Non so come, mi vengono fuori due parole nella loro lingua. Io una volta un po’ la parlavo. Non mi immaginavo l’effetto, in un attimo ce li ho tutti vicini, a parte la signora nel letto, mi prendono la mano, qualcuno sorride addirittura, qualcuno piange. E all’improvviso mi parlano di un bambino. Un bambino che deve morire. Abbassano la voce e mi parlano del ‘mulo’, il fantasma di un bambino morto. Guardano da un lato come se avessero paura, come se ci fosse qualcuno che li potesse sentire. Ma la stanza è vuota. C’è solo il letto bianco rifatto e già aperto, pronto per la dottoressa che deve rientrare dalla Sala. Il ragazzino che corre per i corridoi ora mi scruta con degli occhi neri e aguzzi che si scavano una strada dentro di me come se fossi diventata di creta. Sarà lui il bambino che deve morire? Non è possibile, ci deve essere dell’altro. Capisco che è una storia troppo lunga, che devo assolutamente poter dire qualcosa di vero, qualcosa di concreto a queste persone. Prometto di ritornare al più presto e vado verso le stanze degli infermieri per vedere se qualcuno mi possa aiutare. Per quanto mi ricordo, questa signora ha avuto una reazione allergica al mezzo di contrasto e dopo l’intervento è stata un giorno in rianimazione. "Una brutta storia", mi dice piano la dottoressa guardando lontano davanti a sé. "E te lo dico io, proprio perché sono zingari sono stati trattati così. Quella donna ci stava lasciando la pelle." Non ho il coraggio di chiedere di più. Mi bastano queste due frasi, che mi entrano nello stomaco come una lama. Non lo diceva proprio un’infermiera, che in quella stanza ci voleva una bella bomba, e tutti i problemi si sarebbero risolti? Ma quella storia del bambino, di cui non avevo capito niente? E la dottoressa, come se mi leggesse nel pensiero, continua. "Ora ci mancava anche questo fatto dell’aborto. E’ pazzesco che non abbia capito nulla della contraccezione, non so proprio che si può fare con queste donne straniere. Mi hanno detto che ha fatto una scenata, pianti e urli che non avevano dell’umano. Che vuoi, sono culture diverse, le emozioni le esprimono così." Questa è una vera fortuna, penso subito. Il fatto che la dottoressa abbia dato valore alla mia richiesta, che questa storia l’abbia già toccata in qualche punto della sua anima. Devo prendere al volo questa occasione. Lo so che i dottori si scomodano per le cose importanti. E sicuramente è difficile che un’allieva abbia da dire una cosa importante per un dottore. Ma in questo momento ho trovato solo questa dottoressa, e istintivamente sento che quelle persone devono essere aiutate. Che non c’è tempo da perdere… La dottoressa mi dice di si. Mi dice: "Andiamo, vieni pure con me". Fuori dalla porta un visino si affaccia per un attimo e scompare. Vuoi vedere che quel bambino mi ha seguito fino alla medicheria? Quando la dottoressa arriva nella stanza, sono tutti silenziosi. La signora nel letto fa un sospiro, si solleva con cautela mentre il braccio fasciato sembra più grande e fa una strana curva, come se il dolore vi tracciasse intorno una rete invisibile. "Dottoressa aiutami, non voglio morire, che cosa ho fatto di male, non ho mai fatto niente a nessuno dottoressa ti giuro." Strano ma vero, questa cosa torna sempre fuori, non si vuole accettare che buoni e cattivi soffrono tutti, che non vuol dire niente se uno è bravo o non lo è, che tutto questo fa parte della vita. La dottoressa parla dolcemente, spiega che la signora sta meglio, tant’è vero che è rientrata dalla rianimazione, che d’ora in poi tutto andrà a migliorare. Nessuno fiata. Ed ecco che la signora si mette a piangere. "Ma il bambino… lui non deve morire, è una vita". E la dottoressa le risponde quasi sottovoce: "Non può vivere quel bambino, tu in questo momento non puoi dargli la vita, è un momento difficile, lo sai anche tu. Quando esci da qui, devi andare all’ appuntamento che ti abbiamo preso, lì ti spiegheranno tutto, potrai domandare quello che vuoi." La signora continua a piangere, suo marito la guarda senza sapere cosa dire. Fuori dalla finestra si sente il frastuono dei martelli pneumatici. L’ospedale è tutto un cantiere, si demoliscono edifici consunti, sbiaditi dal tempo, le betoniere ruotano senza fine, qua e là sorgono fondamenta, piloni bianchi crescono tendendo verso il cielo le loro anime di ferro. "E’ una vita", la signora ripete tra i singhiozzi, "una vita nuova, una vita che deve andare avanti, allora è meglio io, è meglio se mi fermo io." La dottoressa si volge verso di me. "Diglielo tu, se parli la sua lingua, diglielo che la vita rimane in lei, che se adesso il bambino non può nascere, più avanti, quando starà meglio, la vita nuova ritornerà… perché la vita nuova non si ferma mai…" E la dottoressa deve andare, saluta gentilmente e mi lascia in mezzo a loro, mentre il ragazzino mi prende la mano e mi domanda: "Ma la vita nuova che colore ha? E che sapore? Deve avere il sapore del pane appena fatto, non è vero?" Mi porta dalla mamma, lo seguo e ad un certo punto siamo tutti stretti intorno a lei. L'abbraccio con estrema attenzione. Lei fa passare attorno a me il suo braccio sano, sento accanto al mio collo la sua testa leggera, scossa ritmicamente dai singhiozzi. E’ sudata, piena di lacrime, ad ogni sussulto il tubo del drenaggio che ha nel petto oscilla lievemente. "Quella bottiglia" mi dice la suocera con la voce quasi da uomo. "E’ di là che la vita se ne sta andando, un poco alla volta." Non riesco a risponderle, più tardi le spiegherò cos’ è un drenaggio, e tutto quello che vorrà sapere. Me lo prometto. Ma ora mi sembra che questo momento sia già troppo pieno delle cose che sono state dette. Questo momento deve soltanto passare. Ed è un momento che non mi appartiene. Queste persone devono ritrovarsi, il mio compito ora è finito. La signora si asciuga le lacrime con la mano, il respiro si sta normalizzando, e questo è già qualcosa. Saluto tutti, esco quasi in punta dei piedi. Sento che devo far ordine nella mente. Spiegarmi un po’ tutte queste cose. Pensare a come si può gestire una verità così cruda, così assurda, che ti sfida tutti i giorni. Se si può trovare una strada interna che ti porta al punto nascosto dove tutto nasce, dove tutto si forma… dove le culture, le razze non esistono e uno è soltanto uomo, o donna, o bambino. Ed ecco di nuovo accanto a me, una testolina scura, arruffata. Il ragazzino mi si pianta davanti e mi chiede "Come ti chiami?" Mentre gli rispondo, mi accorgo che mi sta parlando nella sua lingua. Lui che parla l’italiano così bene, con un accento inequivocabilmente fiorentino! Sicuramente questo bambino va a scuola. Mi rendo conto di averlo visto tante volte e di non aver idea di quale possa essere il suo nome. Glielo chiedo. "Mi chiamo Ronaldo, e diventerò un grande calciatore. E quando sarò famoso, mi ricorderò di te ‘ mi dice con una solennità che non può non farmi sorridere. E anche lui sorride, anzi, ride proprio, con quegli occhi lampeggianti, traboccanti di vita. Ai piedi adesso ha delle vere scarpe da calcio, rotte e sformate, me le fa vedere con orgoglio, chissà quando le ha indossate. Per un attimo non c’è più la sofferenza, al suo posto una leggerezza strana, mentre ridiamo insieme senza sapere il perché. Ride anche un’ infermiera che passa veloce, e ride pure quella coppia che sta entrando nel reparto l’uno a braccetto dell’altra, una coppia di mezza età. "Hai visto?" Dice lei al marito. "Questi piccoli brasiliani, il calcio ce l’ hanno proprio nel sangue, non è vero?" E già il bambino ha ripreso le sue corse, in su e in giù. All’improvviso mi par di capire il segreto di quel movimento senza fine. Dell’armonia di quelle piccole gambe abbronzate, di quel corpo dove tutto è accentrato in quell’atto che scandisce un ritmo perfetto che è come un respiro. E’ la bellezza del mondo, la vita, che basta a sé stessa, che non ha bisogno di niente. E che si vuole esprimere, nonostante tutto, anche in un posto così. O forse, proprio in un posto così… E per un momento mi immagino quella linea invisibile che qua dentro la malattia e il dolore tracciano ogni giorno, dove le cose perdono il loro significato o lo cambiano profondamente, anche proprio le differenze tra gli uomini: è come se Ronaldo con la sua corsa leggera potesse attraversare tutti i limiti, tutte le diversità, raccoglierle in qualche modo in sé, l’allegria e il dolore, la lingua materna e il dialetto toscano, il sangue balcanico e il sorriso ‘brasiliano’, le scarpe rotte e la maglia della fiorentina, la sua vitalità e la morte che lo circonda, il rifiuto della gente e la simpatia… E il senso dell’ incontro di tutte le cose? Ci deve essere un senso, penso continuando la mia fantasia, ci deve essere anche se la mia mente si perde. Forse per un attimo l’avevo colto proprio in quel sorriso, così fuori luogo, così coinvolgente, che è come se continuasse ancora da qualche parte nell’ aria, oppure dentro di me? Forse. E pensare che non me ne ero nemmeno accorta…
- 1774 letture