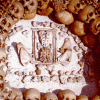La vita cambia in fretta.
La vita cambia in un istante.
Una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita.
Il problema dell’autocommiserazione.
Queste sono le prime parole che Joan Didion, pochi giorni dopo aver perso il marito John, compagno da oltre quaranta anni della propria vita, scrive sul computer, quasi a fermare nella propria mente “quel normale istante” in cui tutta la sua vita subirà una trasformazione completa. Solo dopo molti mesi ritroverà quell’incipit e deciderà di scrivere il racconto dei dodici mesi in cui ha dovuto sopravvivere al suo terribile lutto. “Scrivo per scoprire cosa penso, cosa sto osservando, cosa vedo e cosa vuol dire tutto questo. Per scoprire cosa voglio e cosa temo”: come per altri, scrittori e non, scrivere può essere sia un elemento di sostegno nel processo di elaborazione del lutto, sia un modo per tenere vivo il ricordo di chi non è più fisicamente presente, ma è “dentro” in ogni momento alla propria vita quotidiana.
La scrittura è contenuto ma è anche un contenitore, una forma che si può dare a pensieri che altrimenti si avvitano incessantemente in spirali che sembrano portare alla perdita del significato stesso della vita. La vita senza diventa con la parola scritta una vita con… con la memoria, con il ricordo, con l’eco delle esperienze vissute insieme a chi non c’è più.
In questo libro la scrittrice americana ci conduce, passo dopo passo, in profonde riflessioni sia culturali - molti i riferimenti letterali e filosofici - sia emotive, sul passaggio improvviso dalla normalità della vita al precipizio di dolore determinato dalla morte di una persona cara e a questo - sottolinea più volte - “non siamo mai pronti”.
Il pensiero magico evocato dal titolo riguarda il procedimento psicologico di reazione alla scomparsa di una persona cara, diverso per ciascuno, eppur simile nel tentativo di mantenere aperto il dialogo con chi si sente vicino, pur sapendo che non potrà risponderci: “Scrivere era il mio modo per capire cosa mi stava succedendo, ma innegabilmente anche un modo per prolungare la mia conversazione con John. Terminarlo è stata una dolorosa presa d’atto della sua assenza”; ha dichiarato Joan Didion nell’unica intervista italiana, concessa alla rivista Diario.
Ogni giorno del primo anno di lutto il pensiero torna al giorno in cui la persona che è morta era ancora presente e, in questa sorta di altalena del tempo, chi è vivo cerca di fermare il fluire dei giorni, di ritornare indietro, quasi ciò servisse a riportare la vita dove non c’è più. Didion descrive con precisione gli istanti in cui le immagini del passato si affacciano all’improvviso, inattese e spiazzanti, trasformando ogni giornata in una sequenza di trabocchetti imprevedibili e magnetici: d’un tratto non sei più per strada o in un negozio, non stai più parlando con la tua vicina di casa o bevendo un bicchier d’acqua, è come se una corrente ti trascinasse lontano, dove solo tu puoi stare e nessuno può seguirti.
Per questo chi è in lutto si assomiglia, come se portasse sul volto le stimmate del trauma subito, un’espressione – scrive – “forse riconoscibile solo da coloro che hanno vissuto quell’espressione sul proprio viso. Io l’ho notata sul mio e ora la noto sugli altri. E’ una espressione di estrema vulnerabilità, nudità, trasparenza”.
Donne e uomini nudi perché si sentono invisibili, come se avessero attraversato una frontiera, o uno di quei fiumi leggendari che separano i vivi dai morti. E’ con questa consapevolezza che Didion si accosta a un tema cruciale per la nostra epoca, per lo meno nel ricco occidente, quello della rimozione della morte, della sua espulsione che ci affanniamo a perpetuare, intimoriti e affannati, per lasciar spazio al trionfo della vita, un trionfo certo più ideale che reale. E infatti, “quando succede”, ognuno coglie la necessità di un rito, di un segno che ci renda riconoscibili per poter accogliere la morte ed essere accolti da chi sa stare accanto rispettando il dolore.
Didion si accorge di quanto sia vero quanto scriveva Philippe Ariès nel 1973 riguardo alla rivoluzione nell’atteggiamento verso la morte che “così onnipotente nel passato da essere familiare, sarebbe stata cancellata, sarebbe diventata vergognosa e tabù” e quanto manchi all’attuale società la capacità di darsi rituali utili soprattutto nelle prime fasi di elaborazione.
Quello che salva è la vicinanza di persone sensibili, capaci di “esserci” e porgere un aiuto concreto (“non dimenticherò l’istintiva saggezza dell’amica che tutti i giorni in quelle prime settimane mi portava da Chinatown un recipiente da un litro di crema di riso: era l’unica cosa che riuscivo a mangiare”), senza invadere gli spazi in cui inizia a vivere da sola o rompere quel silenzio a cui si deve abituare: “Avevo bisogno di stare sola perché lui potesse tornare indietro: questo è l’inizio del mio anno del pensiero magico”.
Attraversando il proprio anno di dolore, l’autrice ci consegna pagine intense sul valore dell’amore, del matrimonio, del tempo, e della capacità di sopravvivere, che si fonda sulla volontà e anche sulla necessità.
“Oggi mi sono accorta per la prima volta che il mio ricordo di questo giorno un anno fa è un ricordo che non riguarda John. Questo giorno un anno fa era il 31 dicembre 2003. John non vide questo giorno un anno fa. John era morto. Quando mi è venuto in mente questo stavo attraversando Lexington Avenue. So perché ci sforziamo di impedire ai morti di morire: ci sforziamo di impedirglielo per tenerli con noi. So anche che, se dobbiamo continuare a vivere, viene il momento in cui dobbiamo abbandonarli, lasciarli andare, tenerceli così come sono, morti”.
Il bisogno di dare un senso e una direzione alla vita spezzata, a quella ferita che non si rimargina, di trovare un perché, quando la vita “cambia in un normale istante”- come Didion ripete quasi in una litania – la porta a consultare numerosi articoli scientifici che parlano sia delle malattie che degli eventi accidentali che procurano la morte, ripercorrendo le varie fasi degli interventi di emergenza effettuati su John che non hanno potuto modificarne la sorte, fino all’attesa dei riscontri dell’autopsia, quasi per voler esorcizzare la paura di scoprire che… altrimenti si sarebbe potuto salvare.
Solo dopo qualche mese, finalmente, Joan Didion riesce a rimettersi a scrivere, comprendendo che, mentre fino ad allora era stata capace solo di affliggersi e “il dolore era passivo, il dolore c’era e basta”,per elaborare il lutto, che è il modo di affrontare la sofferenza, occorreva prestarvi attenzione, non evitarla distraendosi.
Infatti il dolore risulta essere un posto che nessuno conosce finché non ci arriva e troppo si confida sul fatto che “il tempo” potrà guarirlo, quando invece occorre impegnarsi per poter continuare a vivere e non limitarsi a sopravvivere.
E, dopo un anno, Didion si accorge che qualcosa sta cambiando, ci sono ricordi in cui il marito non è più presente, mentre lei nel frattempo ha dovuto anche assistere la sua giovane figlia Quintana, da poco sposata, fino alla morte dopo numerosi ricoveri ospedalieri e l’alternarsi di speranza e disperazione: “Improvvisa o annunciata, la morte non è comprensibile, forse con il tempo la si accetta”.
Anche se spesso ci capita di dire, specie quando invecchiamo e assistiamo alle morti che toccano altri: “quando mi succederà qualcosa…” in realtà, siamo sempre impreparati di fronte all’esperienza della morte che riguarda noi da vicino; così nelle coppie, dopo anni di convivenza, si è “incapaci di immaginare la realtà della vita senza l’altro”, perché solo i superstiti di una morte vengono lasciati soli veramente: i legami che formano la vita quotidiana svaniscono e ci si deve reinventare ogni giorno un significato nuovo perché le normali abitudini sono perse per sempre.
Joan Didion sottolinea un aspetto molto profondo anche del matrimonio che “è memoria, è tempo ma anche, paradossalmente, la negazione del tempo perché ci si vede con gli occhi dell’altro”, quasi ci sembra di non invecchiare perché… lo si fa insieme e contemporaneamente.
Poi all’improvviso l’altro muore e “noi piangiamo la sua scomparsa, ma soprattutto piangiamo anche noi stessi: come eravamo, come non siamo più, come un giorno non saremo affatto”. Ed è qui che si trova anche il senso di quell’atto di commiserazione, quel rivolgersi continuamente a se stessi che, come lei stessa ammette per averlo provato “prima”, quasi infastidisce coloro che non hanno vissuto un lutto e guardano con diffidenza e distacco le persone che ne fanno esperienza.
Nel parlare di questo libro è necessario ricorrere di continuo alle parole del testo, citarne frasi e osservazioni perché le emozioni trasmesse in questa sorta di diario compongono un mosaico di risonanze valide per esperienze anche molto diverse: magari le abbiamo già lette altrove, ma ci arrivano con inedite delicatezza e sensibilità e sono frutto di un pensiero creativo che, insieme, induce a generare nuove riflessioni.
E’ dunque un libro che può essere di aiuto e di conforto per chi vive una situazione di lutto, o per chi, per professione o in associazioni di volontariato, sta vicino a persone in lutto.
Suggerisce atteggiamenti di ascolto, attenzione, rispetto e riservatezza e, insieme, stimola a reinventare forme adeguate, anche rituali, di condivisione. Secondo un antico proverbio africano, sono i vivi che chiudono gli occhi ai morti e i morti che aprono gli occhi ai vivi e in questo libro Didion offre a tutti noi la possibilità di non distogliere lo sguardo da ciò che, inevitabilmente, fa parte della nostra vita.
- 8469 letture